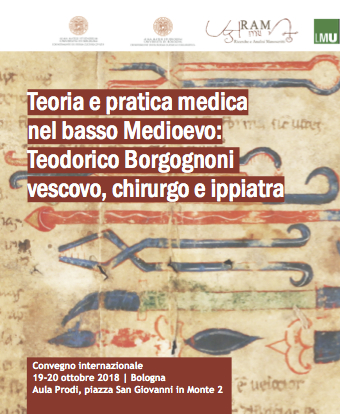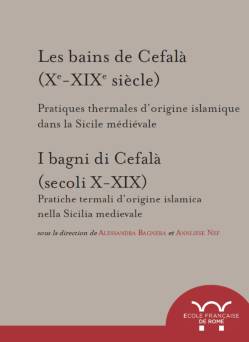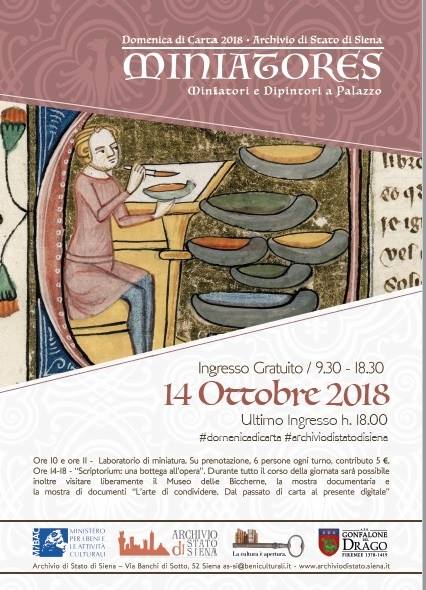In occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018
#EuropeForCulture, la Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto (TN) organizza lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 17,00 l’incontro con Franco Cardini, storico del Medioevo, saggista, editorialista sul tema: Il Medioevo, alle radici della cultura europea.
Lo studioso, introdotto dalla latinista dell’Università di Trento
Caterina Mordeglia, parlerà del ruolo fondamentale svolto dall’età di
mezzo quale momento di codificazione e trasmissione del patrimonio
culturale antico nell’Occidente europeo fino alla modernità.
Franco Cardini, storico del Medioevo, ha insegnato all’Università di Firenze e
attualmente fa parte del Consiglio scientifico della Scuola Superiore
di Studi Storici di San Marino. E’ direttore di Ricerca nell'École des
Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e fellow della Harvard
HYPERLINK "https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard_University"University.
Saggista ed editorialista per diverse testate nazionali e
internazionali, è stato membro del CDA della RAI negli anni 1994-1996.
Tra i suoi ultimi libri: La via della seta. Una storia millenaria tra Oriente e Occidente (2017); L’Islam è una minaccia. Falso! (2016); L’ipocrisia dell’Occidente (2015); La croce, la spada, l’avventura. Introduzione alla crociata (2009).
Rassegna stampa quotidiana di news, eventi informazioni culturali in diretta dal Medioevo realizzata dall'Associazione Culturale Italia Medievale. Pagina con aggiornamento ad intervalli NON regolari. Non rientrante nella categoria della informazione periodica stabilita dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62. Se desideri vedere il tuo evento segnalato in questo spazio scrivici una mail: info@italiamedievale.org
mercoledì 31 ottobre 2018
Studiare il passato, progettare il futuro. I primi tre anni del progetto nEU-Med
Per scaricare il programma completo in formato PDF clicca qui !
Etichette:
archeologia,
conferenze,
medievale,
medioevo,
paesaggio,
ricerca,
tavola rotonda
martedì 30 ottobre 2018
"Il paesaggio degli arcivescovi" presentazione a Pesaro
Per la serie “Pesaro Storie”, condotta dalla Società pesarese di studi storici in collaborazione con il Comune di Pesaro, mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 17,30 nella sala convegni (g.c.) di Confindustria di Pesaro e Urbino (via Cattaneo, 34 – Pesaro) viene presentato il libro di Daniele Sacco "Il paesaggio degli arcivescovi. Processi di trasformazione del territorio tra alto e basso Medioevo nelle Marche settentrionali" (All'Insegna del Giglio 2018, pp. 248).
L’autore ne discute con Tommaso di Carpegna Falconieri, docente di Storia medievale presso l’Università di Urbino e presidente della scuola di Lettere, Arti, Filosofia presso la stessa università.
L’autore ne discute con Tommaso di Carpegna Falconieri, docente di Storia medievale presso l’Università di Urbino e presidente della scuola di Lettere, Arti, Filosofia presso la stessa università.
Si può fare archeologia del paesaggio basandosi soprattutto su fonti documentarie? Questo studio, che si occupa di un'area medio-adriatica posta nella parte nord della provincia di Pesaro e Urbino, al confine con la Romagna, dimostra che si può, e che attraverso questa indagine è possibile comprendere l’evoluzione nei secoli di un contesto che vide attive tre pievi – quelle di San Cristoforo, di San Pietro e di Santa Sofia – e sette castelli dal diverso destino: Casteldimezzo, Fanano, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Gradara, Granarola e Monte Corbino.
Il territorio in questione è oggi in gran parte vincolato dalla presenza di un parco naturale regionale. Percorsa dalla Flaminia e interessato dallo scalo marittimo di Focara (oggi Vallugola), l’area era fiorente già in età romana e costituiva un importante nodo viario e socio-economico. Fu però nel Medioevo che queste terre ebbero una particolare fioritura, sotto il controllo degli arcivescovi di Ravenna. Lo studio di Sacco indaga diacronicamente le tante sfaccettature di quel paesaggio: l'aspetto demico, l'assetto dell'habitat, l'entità delle coltivazioni e persino i nomi dei fondi agricoli e dei loro fittavoli bassomedievali. Il lavoro è arricchito da una serie di mappe, da immagini restitutive di Ettore Zonzini e da fotografie odierne dei luoghi trattati.
Daniele Sacco insegna Archeologia cristiana e medievale presso l'Università di Urbino. Si occupa di archeologia dei processi di trasformazione del paesaggio, del popolamento e dell'edilizia storica tra Tardoantico e basso Medioevo, con particolare attenzione al rapporto tra società e habitat. I suoi temi d'approfondimento sono la fine del paesaggio antico, l'incastellamento, i sistemi produttivi della pietra, le forme di assistenza ospedaliera, il fenomeno del pellegrinaggio. Ha condotto scavi stratigrafici, indagini topografiche, indagini di archeologia degli elevati. Autore di saggi e ricerche, è attivo sul fronte della divulgazione attraverso la collaborazione con il “Il Resto del Carlino”, dove cura delle rubriche.
Daniele Sacco insegna Archeologia cristiana e medievale presso l'Università di Urbino. Si occupa di archeologia dei processi di trasformazione del paesaggio, del popolamento e dell'edilizia storica tra Tardoantico e basso Medioevo, con particolare attenzione al rapporto tra società e habitat. I suoi temi d'approfondimento sono la fine del paesaggio antico, l'incastellamento, i sistemi produttivi della pietra, le forme di assistenza ospedaliera, il fenomeno del pellegrinaggio. Ha condotto scavi stratigrafici, indagini topografiche, indagini di archeologia degli elevati. Autore di saggi e ricerche, è attivo sul fronte della divulgazione attraverso la collaborazione con il “Il Resto del Carlino”, dove cura delle rubriche.
Etichette:
alto medievo,
archeologia,
arcivescovi,
libri,
medievale,
medioevo,
presentazioni
Ubicazione:
Via Carlo Cattaneo, 34, 61121 Pesaro PU, Italia
lunedì 29 ottobre 2018
"Multa magna et mirabilia" convegno a Udine
Per maggiori informazioni e programma completo clicca qui !
Ubicazione:
Via Tarcisio Petracco, 8, 33100 Udine UD, Italia
domenica 28 ottobre 2018
Corradino di Svevia (1257-1268)
Per maggiori informazioni e programma completo clicca qui !
Etichette:
anniversario,
Corradino di Svevia,
incontri,
medievale,
medioevo,
svevi
Ubicazione:
Corso Umberto I, Napoli NA, Italia
sabato 27 ottobre 2018
"Ferraja 1299" Festival Medievale
Per maggiori informazioni clicca qui !
Etichette:
arcieri,
combattimenti,
corteo,
danze,
medievale,
medioevo,
sbandieratori
Ubicazione:
57037 Portoferraio LI, Italia
venerdì 26 ottobre 2018
"Il Campidoglio fuori Roma" presentazione a Cori (LT)
Per maggiori informazioni clicca qui !
Etichette:
libri,
medievale,
medioevo,
podestà,
presentazioni
Ubicazione:
Via Giacomo Matteotti, 04010 Cori LT, Italia
giovedì 25 ottobre 2018
Santa Ildegarda di Bingen, dottore della chiesa
Per maggiori informazioni e programma completo clicca qui !
mercoledì 24 ottobre 2018
Sturm und drang: Medioevo romantico fra storia e letteratura
Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 17.00, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena prosegue il ciclo di conferenze "Medievalismi" con Francesca Roversi Monaco che parlerà di "Sturm und drang: Medioevo romantico fra storia e letteratura".
Il Medioevo è stato serbatoio inesauribile di immagini, narrazioni, leggende fin dal Quattrocento, ma è con il Romanticismo che il mito medievale si diffonde in tutta Europa, segnando in maniera indelebile la letteratura, l’arte, la politica, la società. Il Romanticismo, infatti, ha fornito alla società occidentale un Medioevo metastorico e atemporale, un palcoscenico dai contorni sfumati dove rappresentare attraverso i personaggi della leggenda e della fiaba, dell’avventura e del sentimento, le passioni, le pulsioni, i desideri e le struggenti malinconie del presente.
Francesca Roversi Monaco insegna a Bologna Storia medievale, Storia della storiografia medievale e Fonti per lo studio del paesaggio e del territorio e si occupa di storiografia e di medievalismo. Fra i suoi lavori si segnalano Il Comune di Bologna e re Enzo. Costruzione di un mito debole (2012), Conflitti oligarchici nella Bologna di Annibale I Bentivoglio (2012) e gli articoli O falsar la storia: Massimo d’Azeglio e la Lega Lombarda, Il medioevo contraffatto di Emma Perodi: l’ombra del sire di Narbona, Medioevo quante storie, Fulgens regina. Modelli femminili nella scrittura storica longobarda, Scripta manent. La scrittura storica e la fondazione della memoria.
Il Medioevo è stato serbatoio inesauribile di immagini, narrazioni, leggende fin dal Quattrocento, ma è con il Romanticismo che il mito medievale si diffonde in tutta Europa, segnando in maniera indelebile la letteratura, l’arte, la politica, la società. Il Romanticismo, infatti, ha fornito alla società occidentale un Medioevo metastorico e atemporale, un palcoscenico dai contorni sfumati dove rappresentare attraverso i personaggi della leggenda e della fiaba, dell’avventura e del sentimento, le passioni, le pulsioni, i desideri e le struggenti malinconie del presente.
Francesca Roversi Monaco insegna a Bologna Storia medievale, Storia della storiografia medievale e Fonti per lo studio del paesaggio e del territorio e si occupa di storiografia e di medievalismo. Fra i suoi lavori si segnalano Il Comune di Bologna e re Enzo. Costruzione di un mito debole (2012), Conflitti oligarchici nella Bologna di Annibale I Bentivoglio (2012) e gli articoli O falsar la storia: Massimo d’Azeglio e la Lega Lombarda, Il medioevo contraffatto di Emma Perodi: l’ombra del sire di Narbona, Medioevo quante storie, Fulgens regina. Modelli femminili nella scrittura storica longobarda, Scripta manent. La scrittura storica e la fondazione della memoria.
martedì 23 ottobre 2018
Il drago e altre creature fantastiche: le radici bibliche dell'immaginario medievale
Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 18,00 presso la Sala attigua alla Libreria Claudiana in Via Francesco Sforza, 12/a a Milano si tiene la conferenza "Il drago e altre creature fantastiche: le radici bibliche dell'immaginario medievale" a cura di Luca Frigerio.
Dice
“drago” l’uomo o la donna del Medioevo e dice orrore: simbolo di
malvagità, creatura delle tenebre, bestia immonda contro cui non c’è
scampo se non invocando la protezione celeste. E accanto al drago, ecco
pure le sirene, i grifoni, i centauri, le chimere, il basilisco… Tutto
un mondo fantastico, illustrato nei codici miniati, scolpito nei
chiostri monastici, dipinto a vivaci colori sulle pareti delle chiese.
Ma da dove scaturivano simili fantasmagorie? Ce lo spiegherà Luca
Frigerio, autore di: Medioevo fantastico. Il drago e altri mostri (ed.
Ancora, 2018). Con lui scopriremo che questo incredibile immaginario
medioevale è in realtà intriso di profonda spiritualità cristiana e
individua i suoi fondamenti non solo nei miti antichi, ma soprattutto
nelle Sacre Scritture. E’ infatti rileggendo e meditando la Bibbia che
il Medioevo trova il primo nutrimento della propria fede.
Serata con proiezione di immagini
Per infornazioni: tel. 02.76.02.15.18
Ingresso libero
Etichette:
bibbia,
conferenza,
draghi,
medievale,
medioevo
lunedì 22 ottobre 2018
"ll Medioevo, alle radici della cultura europea" Cardini a Rovereto
Per seguire l'evento su Facebook clicca qui !
domenica 21 ottobre 2018
Giornata delle dimore storiche del Lazio
Domenica 21 ottobre 2018 sarà possibile accedere gratuitamente in 72 luoghi storici
da scoprire in tutta la loro ricchezza. L’iniziativa, denominata
“Giornata delle dimore storiche del Lazio”, è stata presentata dal
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore
regionale al Turismo, Lorenza Bonaccorsi, alla sede dell’ex Gil di
Trastevere.
Roma, Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo sono le province della regione Lazio che hanno aderito al progetto.
Obiettivo della pianificazione, secondo la Regione, sarà quello di scoprire parte dell’immenso patrimonio di dimore, ville, parchi e giardini storici su tutto il territorio del Lazio che sono inseriti nella rete delle dimore storiche costituita nel 2017.
Roma, Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo sono le province della regione Lazio che hanno aderito al progetto.
Obiettivo della pianificazione, secondo la Regione, sarà quello di scoprire parte dell’immenso patrimonio di dimore, ville, parchi e giardini storici su tutto il territorio del Lazio che sono inseriti nella rete delle dimore storiche costituita nel 2017.
Il ninfeo di Bramante e il castello Colonna a Genazzano, il castello
Theodoli di Ciciliano, il complesso di Monterano, il castello Massimo di
Arsoli, palazzo Chigi ad Ariccia. Ed ancora, il castello di Rocca
Sinibalda, l’abbazia di San Pastore a Greccio, palazzo Latini a Collalto
Sabino, la rocca dei Farnese a Cellere, il castello di Civitella Cesi
di Blera, il casale delle Cignacce a Roma, questi e molti altri luoghi
saranno aperti al pubblico.
Un’iniziativa straordinaria con cui la Regione Lazio vuole offrire a
cittadini e turisti la possibilità di conoscere e visitare un patrimonio
storico-culturale unico al mondo: dimore, ville, complessi
architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e
storico-artistico.
Tutti i siti fanno parte della Rete regionale, curata dall’Area
Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Direzione regionale
Cultura e Politiche giovanili.
Fanno parte della Rete le dimore pubbliche e private che hanno presentato domanda di adesione e che possiedono i requisiti indicati nell’avviso pubblico della Legge Regionale 8 del 2016. La Rete verrà aggiornata annualmente ed è destinata a crescere, per offrire a tutti la possibilità di scoprire e riscoprire la bellezza del Lazio.
Fanno parte della Rete le dimore pubbliche e private che hanno presentato domanda di adesione e che possiedono i requisiti indicati nell’avviso pubblico della Legge Regionale 8 del 2016. La Rete verrà aggiornata annualmente ed è destinata a crescere, per offrire a tutti la possibilità di scoprire e riscoprire la bellezza del Lazio.
Un’occasione imperdibile per scoprire questi luoghi in cui il fascino e la suggestione della storia sono rimasti intatti.
Questo è il sito ufficiale delle dimore storiche laziali: www.dimorestorichelazio.it.
Etichette:
abbazia,
castelli,
dimore,
medievale,
medioevo,
rinascimento,
visite guidate
Ubicazione:
Lazio, Italia
sabato 20 ottobre 2018
Jacopo della Quercia e la Madonna della melagrana
Dopo il grande successo del primo appuntamento
lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 17.30 torna a Palazzo Bonacossi "Anatomia di
un capolavoro. Storia, stile e iconografia nelle opere del Museo della
Cattedrale". Il secondo appuntamento del ciclo di conferenze
vedrà ospite un'altra personalità di assoluto prestigio: la storica
dell'arte Laura Cavazzini che illustrerà il fulcro di questa edizione:
la Madonna della melagrana di Jacopo della Quercia.
Capolavoro assoluto della storia dell'arte italiana, la grandiosa Madonna del Museo della Cattedrale rappresenta una delle poche testimonianze del Rinascimento sopravvissute alle spoliazioni cui Ferrara fu oggetto nel corso dei secoli. Un'opera in passato molto amata dai ferraresi che coniarono per lei nel Sei e Settecento gli affettuosi soprannomi di "Madonna bianca" o di "Madonna del pane", quest'ultimo a causa del cartiglio arrotolato nella mano sinistra del Bambino così simile alla "coppia" ferrarese. Scolpita tra il 1403 e il 1406 per adempiere alle volontà testamentarie di Virgilio Silvestri, camerlengo di Niccolò III, la scultura fu percepita sin dal suo apparire come un'opera fuori dall'ordinario a causa delle sue notevoli dimensioni e della sua straordinaria qualità. Guidati da Laura Cavazzini il pubblico potrà così riscoprire questo capolavoro di possente grazia e al contempo inquadrare l'arte di Jacopo della Quercia (Siena, 1374 circa - 1438) che, proprio per le doti espresse nell'opera ferrarese, sarà poi apprezzata a Siena, Lucca e Bologna.
Laura Cavazzini è professore associato di Storia dell'Arte Medievale all'Università di Trento. I suoi studi sono principalmente rivolti alla cultura artistica del Gotico internazionale, all'architettura, alla scultura e all'oreficeria nella Valle padana fra Due e Quattrocento, al Rinascimento toscano. Su questi argomenti ha pubblicato articoli in riviste e in volumi miscellanei e il libro Il crepuscolo della scultura medievale in Lombardia (Firenze, Olschki 2004). Ha collaborato alla realizzazione di varie mostre, tra cui Il fratello di Masaccio (San Giovanni Valdarno 1999); Masaccio e le origini del Rinascimento (San Giovanni Valdarno 2002); Il Gotico nelle Alpi (Trento 2002); Mantegna, 1431-1506 (Parigi 2008); Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento (Siena 2010); Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano al centro dell'Europa (Milano 2015).
Il ciclo di conferenze, con ingresso gratuito, si concluderà lunedì 29 ottobre, sempre alle 17.30 a Palazzo Bonacossi, con Fabio Bevilacqua e il suo intervento dedicato alla tecnica scultorea del grande maestro senese.
Capolavoro assoluto della storia dell'arte italiana, la grandiosa Madonna del Museo della Cattedrale rappresenta una delle poche testimonianze del Rinascimento sopravvissute alle spoliazioni cui Ferrara fu oggetto nel corso dei secoli. Un'opera in passato molto amata dai ferraresi che coniarono per lei nel Sei e Settecento gli affettuosi soprannomi di "Madonna bianca" o di "Madonna del pane", quest'ultimo a causa del cartiglio arrotolato nella mano sinistra del Bambino così simile alla "coppia" ferrarese. Scolpita tra il 1403 e il 1406 per adempiere alle volontà testamentarie di Virgilio Silvestri, camerlengo di Niccolò III, la scultura fu percepita sin dal suo apparire come un'opera fuori dall'ordinario a causa delle sue notevoli dimensioni e della sua straordinaria qualità. Guidati da Laura Cavazzini il pubblico potrà così riscoprire questo capolavoro di possente grazia e al contempo inquadrare l'arte di Jacopo della Quercia (Siena, 1374 circa - 1438) che, proprio per le doti espresse nell'opera ferrarese, sarà poi apprezzata a Siena, Lucca e Bologna.
Laura Cavazzini è professore associato di Storia dell'Arte Medievale all'Università di Trento. I suoi studi sono principalmente rivolti alla cultura artistica del Gotico internazionale, all'architettura, alla scultura e all'oreficeria nella Valle padana fra Due e Quattrocento, al Rinascimento toscano. Su questi argomenti ha pubblicato articoli in riviste e in volumi miscellanei e il libro Il crepuscolo della scultura medievale in Lombardia (Firenze, Olschki 2004). Ha collaborato alla realizzazione di varie mostre, tra cui Il fratello di Masaccio (San Giovanni Valdarno 1999); Masaccio e le origini del Rinascimento (San Giovanni Valdarno 2002); Il Gotico nelle Alpi (Trento 2002); Mantegna, 1431-1506 (Parigi 2008); Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento (Siena 2010); Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano al centro dell'Europa (Milano 2015).
Il ciclo di conferenze, con ingresso gratuito, si concluderà lunedì 29 ottobre, sempre alle 17.30 a Palazzo Bonacossi, con Fabio Bevilacqua e il suo intervento dedicato alla tecnica scultorea del grande maestro senese.
Per seguire l'evento su Facebook clicca qui !
venerdì 19 ottobre 2018
Teodorico Borgognoni vescovo, chirurgo e ippiatra
Per scaricare il programma completo in formato PDF clicca qui !
Etichette:
anatomia,
Bologna,
chirurgia,
convegno,
domenicani,
francescani,
medicina,
medievale,
medioevo
giovedì 18 ottobre 2018
L’arte della calligrafia e della miniatura medievale
"L’arte della calligrafia e della miniatura medievale" incontro che si tiene a Genova giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 18,30 in Via Roma, 8b, organizzato da Genova Cultura.
Prima dell’invenzione della stampa
compilare libri richiedeva una stesura accurata del testo, eseguita con
grande perizia ed alta competenza artistica per la realizzazione delle
finissime decorazioni. I maestri calligrafi componevano il testo su
pregiate pergamene con penne d’oca e inchiostri, utilizzando calligrafie
esteticamente piacevoli che avevano esse stesse una funzione
decorativa. Tali scritture sono cambiate a seconda dei tempi e dei
luoghi; si possono citare ad esempio la Minuscola Carolina dell’impero
Carolingio, la Textura Quadrata (detta oggi gotica) del XII-XIII secolo
francese e la sobria Minuscola umanistica, usata dai dotti del ‘400. Le
pagine erano poi impreziosite dai miniatori con elaborati capo-lettera
decorativi dai vivaci colori temperati con l’uovo e inserti in oro. Gli
strumenti e i materiali usati erano quasi sempre prodotti in bottega o
tra le mura del convento, se l’artefice era un religioso, e a volte
erano ottenuti da materie prime molto preziose che venivano importate da
paesi lontani. Un libro miniato era quindi un oggetto estremamente
costoso, a causa del tempo impiegato per produrlo, dell’elevata
professionalità richiesta e della preziosità dei materiali usati.
Il maestro calligrafo Yuri Zanelli e la maestra d’arte Francesca Cristini,
spinti dalla passione per l’arte medievale, da più di dieci anni si
sono impegnati nello studio accurato degli antichi trattati , con
un’analisi ponderata delle opere che, con gli stessi mezzi e metodi di
allora, hanno fedelmente riprodotto. Grazie alle loro ricerche, ancora
oggi queste antiche tecniche possono rivivere, tramite conferenze e
corsi volti ad avvicinare ad una particolarissima esperienza artistica
sia cultori dell’arte che principianti.
Per seguire l'evento su Facebook clicca qui !
Etichette:
calligrafia,
conferenza,
incontri,
medievale,
medioevo,
miniature
Ubicazione:
Via Roma, 8, 16121 Genova GE, Italia
mercoledì 17 ottobre 2018
Sognare l’Oriente. Il medioevo esotico in Italia
Chi si serve oggi del Medioevo? Tutti. La politica attuale lo usa come
una miniera da cui estrarre esempi e modelli ritenuti utili per capire
il presente. Identifiato con i “secoli bui”, il Medioevo è presentato
come modello perfetto per spiegarci i “nuovi barbari”, lo “scontro di
civiltà” e il terrore che il nostro mondo stia per finire. Al
contrario, se considerato come il tempo dei cavalieri e delle origini
eroiche, il Medioevo assume una funzione mitica per moltissimi gruppi
politici e comunità organizzate, che lo usano per affermare la propria
originale identità. Questa attualizzazione del Medioevo, spesso una vera
e propria invenzione delle tradizioni, va sotto il nome di
“medievalismo”. Quattro appuntamenti dedicati a questo tema si terranno presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena a partire da venerdì 19 ottobre 2018 con Alessandro Vanoli che interverrà su "Sognare l’Oriente. Il medioevo esotico in Italia" in Aula Magna alle ore 17.00.
Il sogno romantico di un medioevo originario ebbe in Italia anche il volto dell’orientalismo. Da una parte il recupero e l’invenzione di una storia antica fatta di incontri e scontri con mori e saraceni; dall’altra il senso orientalistico del recupero di un oriente favoloso, immaginato nelle pitture e persino nei palazzi. Un viaggio dalla Sicilia musulmana ricostruita da storici e architetti, sino ai sogni orientali del castello di Sammezzano e della Rocchetta Mattei.
Il sogno romantico di un medioevo originario ebbe in Italia anche il volto dell’orientalismo. Da una parte il recupero e l’invenzione di una storia antica fatta di incontri e scontri con mori e saraceni; dall’altra il senso orientalistico del recupero di un oriente favoloso, immaginato nelle pitture e persino nei palazzi. Un viaggio dalla Sicilia musulmana ricostruita da storici e architetti, sino ai sogni orientali del castello di Sammezzano e della Rocchetta Mattei.
Alessandro Vanoli,
storico del Medioevo, si è dedicato alla storia del Mediterraneo e
delle relazioni tra cristiani e musulmani tra l’antichità e l’età
moderna. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano Andare per
l’Italia araba (2014), Quando guidavano le stelle. Viaggio sentimentale
nel Mediterraneo (2015), La Sicilia musulmana (2016), L’ignoto davanti a
noi. Sognare terre lontane (2017) e, insieme a Franco Cardini, La via della seta. Una storia millenaria tra Oriente e Occidente (2017).
martedì 16 ottobre 2018
Enrico di Castiglia senatore di Roma (1267-1268)
Etichette:
comuni,
diplomazia,
guerre,
libri,
medievale,
medioevo,
papato,
presentazioni
Ubicazione:
Piazza Navona, 62, 00186 Roma RM, Italia
lunedì 15 ottobre 2018
I Bagni di Cefalà Diana. Pratiche termali d’origine islamica nella Sicilia medievale
Lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 17,00 si presenta a Palazzo Ajutamicristo di Palermo il volume "I Bagni di Cefalà Diana (secoli X-XIX). Pratiche termali d’origine islamica nella Sicilia medievale", edito dall’Ècole Française de Rome, a cura di Alessandra Bagnera e Annliese Nef. Interverranno il Soprintendente Lina Bellanca, Mirella Cassarino, Alessandra Molinari e Renata Prescia. Saranno presenti i curatori del volume.
Il complesso termale di Cefalà Diana, costruito su una sorgente di acqua termale e situato 30 km a sud di Palermo, non era mai stato finora oggetto di uno studio sistematico e interdisciplinare.
I dati archeologici raccolti durante gli scavi effettuati negli anni 1990 e 2000 e le nuove indagini, condotte dal 2003 sotto l'egida della Ecole française de Rome in collaborazione con la Soprintendenza di Palermo, hanno permesso di specificare la cronologia dei bagni e di chiarirne, per la prima volta, le relazioni con il sito in cui si trovano.
domenica 14 ottobre 2018
Miniatores. Miniatori e Dipintori a Palazzo
Per maggiori informazioni e programma completo clicca qui !
sabato 13 ottobre 2018
venerdì 12 ottobre 2018
Iscriviti a:
Post (Atom)